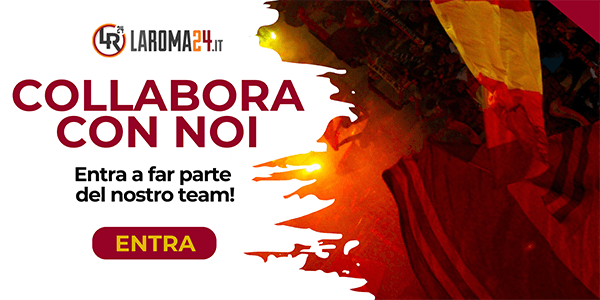Quel rigore era già nato male: non lo aveva decretato l'arbitro il belga Erik Labrechts, connazionale di quel Jean Langenus, il "fischietto" della prima finale mondiale fra Uruguay e Argentina nel 1930 (vinsero i pa-droni di casa "uruguagi", come si diceva una volta degli uruguayani) che aveva accettato l'incarico a due condizioni, un'assicurazione sulla vita e la garanzia che subito dopo il fischio finale sarebbe stato accompagnato su di una nave che aspettava a motori accesi per salpare urgentemente verso l'Europa. Era, questa volta, verso l'80esimo minuto di Roma-Lille, partita di Europa League l'altra sera all'Olimpico. Aissa Mandi, giocatore del Lille, che s'era fatto notare nel bene (suo...) per un salvataggio di piede sulla linea, non s'era fatto notare (nel male) dall'arbitro per un tocco di mano in area sua. Lo chiamavano al Var, la visione era breve, il gesto imperioso ed inequivocabile pur senza l'announcement da simil-balcone. Ora si trovavano l'uno di fronte all'altro, come in "Mezzogiorno di fuoco", la punta della Roma ("piallata" attualmente, ma giorno verrà...) e della Nazionale, l'ucraino Artem Dovbyk, fresco d'ingresso in campo al posto dell'irlandese Ferguson, pure lui sofferente al momento d'un cronico mal di gol, e il portiere del Lille e della Nazionale, il turco Berke Ozer. (...) Neppure gli scienziati di fisica, che hanno studiato che una rincorsa di 5 o 6 passi, percorrendo come un arco fra i 20 e i 30 gradi, mirando a uno dei due angoli alti della porta (dove la traversa incrocia i pali), fissando il bersaglio a "circa" 50 centimetri dall'intersezione, e già una teoria fisica con un "circa" è approssimativa, e scagliando il pallone a 100 chilometri orari, il gol è "quasi" garantito, e anche il "quasi" approssima l'infallibile studio. Che se poi il rigorista fosse mancino, allora, spiega la teoria, avrebbe un 4 per cento di possibilità di fare gol. Anche gli economisti e gli stregoni, per supportare le loro teorie, si sono attaccati al calcio di rigore. (...) Sta che il piè fucile fece una mezza cilecca e le mani pistolere, dopo aver ballonzolato come in un balletto intimidatorio del saltellante portiere, sono arrivate esattamente al punto, che non era quello dell'ideale bersaglio degli scienziati, dove arrivò il pallone. Parato. Ma Ozer s'era mosso prima e troppo avanti: la linea di porta è il limite estremo, chi la passa è perduto. Dunque il rigore era da ripetere. E fu ripetuto. C'è chi dice che se tiri un rigore sempre allo stesso modo allora è probabile che tu acquisisca una tecnica e degli automatismi sempre migliori e più efficaci e che dunque crescano le probabilità di successo. C'è, invece, chi applica la "teoria dei giochi" e ritiene che l'imprevedibilità, alla fine dei conti, sarà più pagante. Dovbyk fu della prima idea: il suo secondo rigore era la fotocopia del primo. E siccome anche la seconda parata di Ozer era la fotocopia della prima, anche l'intervento arbitrale fu la fotocopia del precedente: si ripeta! E tre. Stavolta Roma cambiò il tiratore scelto che fu Soulè, il quale, di suo, cambiò anche la traiettoria: mirò a sinistra. Anche Ozer, però, cambiò il tuffo gettandosi sulla nuova traccia. Fu conoscenza? Fu intuito? Fu semplice fortuna? Chissà. Fu però il fatto che un solo rigore fu sbagliato tre volte (o parato, anche qui la di-scussione è eterna o almeno più che secolare da quando, a fine Ottocento, il rigore fu inventato e suggerito da William McCrum, portiere irlandese: è merito del portiere o demerito del rigorista?). Un fatto insolito: Gasperini, l'allenatore della Roma, ha subito detto «io non l'avevo visto mai, ma forse neppure voi». (...)
(Il Quotidiano Nazionale)