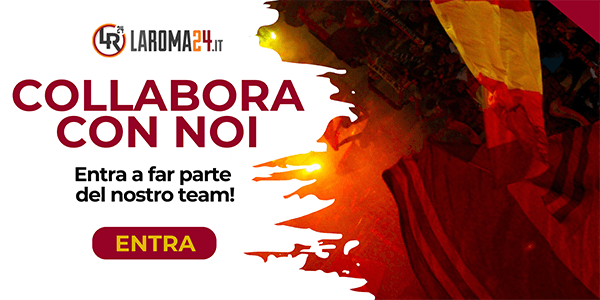IL ROMANISTA (M. IZZI) - Alla scia degli infiniti dolori causata dal lunedì di bufera che si è abbattuto su Roma, arriva anche la notizia del crollo della Madonnina che da sempre vigila sullo Stadio Olimpico. Questo episodio, senzaltro marginale tra tanto dolore e disperazione, ci fornisce lo spunto per alcune riflessioni. Eh sì, perché la caduta della Madonnina nei giorni in cui ancora più serrato è il dibattito sulla tessera del tifoso, ci sembra acquisti un significato profondamente simbolico. La partita vista di sguincio, sotto la Madonnina, ha rappresentato infatti lultimo anello di congiunzione fra la Roma imperiale, quella che proponeva ..
è guardato, si voglia o no, come una potenziale minaccia da dover in qualche modo censire, monitorare, regolamentare. Tra questi due poli (entrambi assai tristi), c’è tutto un mondo di tolleranza, di concezione dello spettacolo sportivo come necessità sociale, diritto da riservare anche a quelle fasce di popolazione che non potevano permettersi l’acquisto del biglietto.
Siamo naturalmente negli anni di Campo Testaccio (di cui a giorni ricorre l’ottantesimo anniversario di fondazione), dove i “portoghesi” dell’epoca si accomodavano sulle pendici del Monte dei Cocci per riuscire a
sbirciare le imprese di Bernardini e compagni. Tra quei tifosi “alpinisti”, sedevano personaggi come Fiorenzo
Fiorentini e Alberto Sordi, che ricordava: «Quando ero ragazzino andavo con i miei amici al Monte dei Cocci per vedere la partita. Solo che mezzo campo non si vedeva, perciò non sapevamo mai il risultato esatto. Allora s’andava tutti al Cinema Vittoria perché c’era er bruscolinaro che, tra un tempo e l’altro del film, ci diceva i risultati. Noi lo chiamavamo Cacarazzi. Dal palco gli urlavamo: “A Cacarazzi dacce i risultati”. Lui si offendeva e se ne andava. E noi accompagnavamo la sua uscita con delle belle pernacchie».
I pochi spiccioli persi per quei biglietti valsero alla Roma un investimento colossale e imperituro. Quanto vale, infatti, aver avuto Alberto Sordi tra le file dei propri tifosi? Come direbbero oggi gli esperti di marketing, si tratta di un ritorno d’immagine incalcolabile. Chiuso Testaccio, lo spirito di tolleranza accompagnò la Roma anche all’Olimpico. Nella stagione 1955/56, la Società organizzò la distribuzione “ai più bisognosi dei gruppi romani” di 2000 impermeabili. Nel decennio successivo il solo XII° Giallorosso di Pietro Maiocchetti, riceveva settimanalmente un quantitativo di tagliandi d’ingresso gratuiti oscillante fra le 50 e le 100 unità. Ancora nel dicembre del 1969, si era arrivati a censite 120 tra cariche e qualifiche che davano, in totale, diritto a 20.000 tagliandi gratuiti di accesso all’Olimpico. In più, c’era la riserva infinita dei posti disponibili sotto la Madonnina. Non era tanto importante ciò che si riusciva effettivamente a vedere, quanto la conquistata sensazione di esserci, di far parte di un evento irripetibile come una partita di calcio … una partita della Roma. Lo stadio Olimpico, allora, era un luogo mitico, che poteva apparire irraggiungibile dalle borgate più lontane o dalla provincia (lo stesso Bruno Conti ha dichiarato di aver varcato i cancelli dell’impianto del CONI solo il giorno del suo debutto in serie A), riuscire ad “esserci”, anche se da una posizione di rincalzo rappresentava un elemento di condivisione che negli anni ottanta, guarda caso, ha consegnato (assieme ad iniziative come quella dello Junior Club) alla Roma una generazione di tifosi irripetibile.
Già dall’inizio dei giorni della contestazione studentesca del 1968, si erano però iniziati ad avvertire, chiarissimi i segnali che qualcosa stava cambiando. Nel luglio del 1965 ad Ezio Radaelli era stato chiesto di trovare nuove formule per incrementare gli introiti del botteghino. Si arrivò alla revisione dei metodi di elezione
del personale di biglietteria, l’AS Roma venne poi privata della possibilità di emettere in maniera autonoma i tagliandi d’ingresso. Gli incidenti scoppiati durante il derby di Coppa Italia del settembre del 1968 e in Roma–
Juventus dell’ottobre dello stesso anno, aprirono la strada a un dibattito che negli anni è divenuto sempre più incalzante. I mondiali del 1990, infine, inflissero un colpo fondamentalmente definitivo al secolare principio del “diritto allo spettacolo sportivo” sacro agli antichi romani. La copertura dell’Olimpico, resa tra l’altro indispensabile dal regolamento che la prevedeva per un impianto chiamato ad ospitare l’ultimo atto di una rassegna iridata, oscurò per sempre la “tribuna esterna” dello stadio capitolino. Il crollo di ieri sembra mettere simbolicamente fine ad una stagione i cui ricordi tendono già a sbiadire, quelli di un calcio in cui sotto la pioggia si poteva ascoltare il suono del pallone colpito trasportato dal vento, quelle di un Olimpico in cui entrando si girava la testa e, indirizzando lo sguardo, ci si chiedeva: «Quanta gente c’è oggi sotto la Madonnina?».